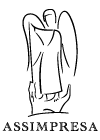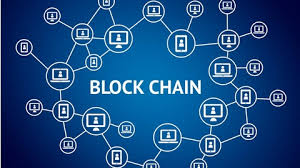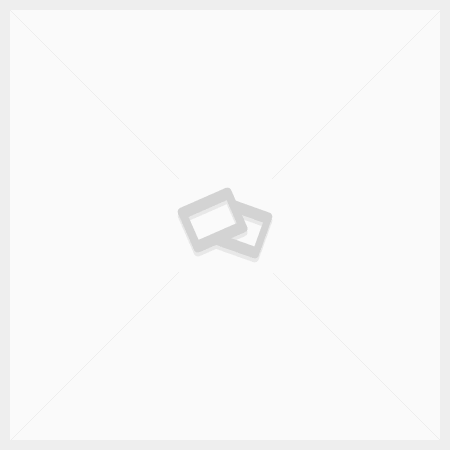DIETRO L’ANGOLO DEL DEF ELETTORALE
Sic rebus stantibus, arriva.
Un Def pre-elettorale ignora l’esigenza di ridurre il debito e rinvia a dopo il voto le riforme pro-euro: verso una meno improbabile imposizione patrimoniale.
Il Def, mano a mano che ne emergono i dettagli, conferma che il governo di centro-sinistra ha messo la politica finanziaria in netta modalità pre-elettorale.
Un dettaglio – neppure troppo piccolo – fra molti: la prima bozza di manovra annuale 2018 include un robusto stanziamento per gli aumenti retributivi dei dipendenti pubblici, sotto minaccia immediata di sciopero generale da parte della Cgil.
Contro le attese della vigilia, è stata invece esclusa la conferma piena a tutto il 2018 dell’iper-ammortamento: il provvedimento di punta della strategia “Industria 4.0”, bandiera della legge di stabilità 2017 e unico indizio tout court di politica economica sviluppista da parte dell’ultimo governo Renzi.
Gli 85 euro di incremento medio promesso ai dipendenti della Pa sembrano far rima quasi baciata con gli 80 euro distribuiti tre anni fa agli italiani da Renzi appena entrato in carica: visti in retrospettiva, una regalìa pura, non seguita da alcun stimolo strutturale per una ripresa che infatti non c’è stata.
È vero, invece, che nel maggio 2014, il Pd incassò il 40,8% alle elezioni europee e su quel risultato Renzi – mai eletto in alcuna consultazione politica nazionale – fondò la sua leadership a palazzo Chigi e nel Pd fino alla sconfitta referendaria di dicembre scorso.
È vero anche che le prossime politiche riavranno con tutta probabilità una formula proporzionalista vicina a quella delle europee.
Dipenderà dalla nuova legge elettorale se la formula risulterà più o meno vicina a quella della Prima Repubblica; quando le finanziarie “elettorali” erano la regola e quando si formarono le prime sacche di insostenibilità nel bilancio pubblico italiano, fra assunzioni di postini e baby-pensioni.
Quegli “sforamenti” (quando ancora i parametri di Maastricht non c’erano) furono pagati in quegli anni n termini di inflazione interna e svalutazione esterna.
Il lungo ingresso nell’euro, negli anni ’90, è stato pagato essenzialmente con privatizzazioni massicce. La permanenza nell’euro dopo l’esplosione della crisi globale del 2008 è stata pagata dall’Italia con un’austerity pesantemente recessiva e con forti danneggiamenti al sistema bancario. Ora la ricostruzione dell’Europa – ammesso che le forze populiste non prevalgano in Francia e Germania – imporrà all’Italia il rientro da un debito “oltre la linea rossa” del 130% del Pil: secondo solo a quello della Grecia.
Il dato più plateale – e drammatico – del Def è appunto il rifiuto di immaginare arretramenti minimi del parametro-chiave sia nel 2017 che nel 2018.
La ripresa non c’è stata e – dopo cinque anni di governo di centro-sinistra – la spending review resta una buona intenzione, mentre sulle privatizzazioni è in atto addirittura una frenata.
Chi pagherà il prossimo conto dell’Italia europea, naturalmente dopo le elezioni?
Fra Pd renziano, sinistre italiane assortite, M5S e Lega l’unica idea – implicita e per molti versi condivisa – è un’imposta patrimoniale.
Populista e disruptiva almeno quanto l’uscita dall’euro propugnata dai populisti “ufficiali”.